 Dieci anni fa si spegneva Giorgio Gaber. «E allora?» direte voi. E allora vorrei dedicargli otto righe, rispondo io. «Era comunista» obietterete. Touché. Gaber, uomo d'altri tempi, tra gli anni Sessanta e i Settanta riconobbe nella «nuova razza» dei sessantottini slanci e aspirazioni che altrove gli sembravano spenti. Lui, classe 1939, guardava al «movimento» con occhi curiosi; ci finì invischiato. Ne era contento, intendiamoci: ne era tanto entusiasta che si convertì alla musica impegnata, e portò a teatro il tumulto di una generazione che pensava di poter cambiare il mondo. Era la generazione di Autonomia Operaia, di «Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Tze Tung», di quelli che «il discorso va portato avanti nella misura in cui»; quelli che leggevano, leggevano Marx. Non ci possono piacere, e infatti noi con il '68 non c'entriamo nulla. Ma può andarci a genio lo spirito quasi quasi «reazionario» di un Gaber che a metà anni Settanta si faceva beffe del Partito Comunista, dileggiava l'intellettualismo della controcultura, scimmiottava la smania psicanalitica e il sogno della comune.
Dieci anni fa si spegneva Giorgio Gaber. «E allora?» direte voi. E allora vorrei dedicargli otto righe, rispondo io. «Era comunista» obietterete. Touché. Gaber, uomo d'altri tempi, tra gli anni Sessanta e i Settanta riconobbe nella «nuova razza» dei sessantottini slanci e aspirazioni che altrove gli sembravano spenti. Lui, classe 1939, guardava al «movimento» con occhi curiosi; ci finì invischiato. Ne era contento, intendiamoci: ne era tanto entusiasta che si convertì alla musica impegnata, e portò a teatro il tumulto di una generazione che pensava di poter cambiare il mondo. Era la generazione di Autonomia Operaia, di «Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Tze Tung», di quelli che «il discorso va portato avanti nella misura in cui»; quelli che leggevano, leggevano Marx. Non ci possono piacere, e infatti noi con il '68 non c'entriamo nulla. Ma può andarci a genio lo spirito quasi quasi «reazionario» di un Gaber che a metà anni Settanta si faceva beffe del Partito Comunista, dileggiava l'intellettualismo della controcultura, scimmiottava la smania psicanalitica e il sogno della comune.
Perché lui, «comunista» della penultima ora, nel 1974 non diceva: «La famiglia tradizionale fa schifo». La sua era una problematizzazione più raffinata. Diceva: «La famiglia tradizionale fa schifo, ma che faccio quando mi accorgo di non poterne fare a meno?». Non sventolava bandiere rosse, ma grattava lì dove i compagni preferivano glissare. Non sognava la rivoluzione: era troppo impegnato ad evidenziare i malanni delle «avanguardie» che la dovevano scatenare. Era un compagno, ma dandosi un'occhiata in giro alla fine degli anni Settanta già se ne vergognava. Nel 1978 non si fece scrupoli a gridare: «Non sono più compagno, né femministaiolo militante. Mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari, e le altre cazzate. E finalmente non sopporto neanche le vostre donne liberate, con cui voi discutete democraticamente. Quando è merda, è merda, non ha importanza la specificazione». A teatro portava il sarcasmo per tutto un mondo che si scioglieva nella sua impotenza, e bersagliava sia le avanguardie che le istituzioni.
All'indomani dell'affaire Moro, vide nelle piazze le bandiere rosse sventolare a fianco delle bianche: era la concordia nazionale, surrogato dello sfiorato compromesso storico tra PCI e DC. Scrisse Io se fossi Dio: Aldo Moro «restava ancora quella faccia che era», nonostante il rapimento, nonostante fosse diventato di punto in bianco un eroe, nonostante la pietà istituzionale. A questa era allergico, il signor G. Così come non sopportava lo Stato: lo considerava la «macchia nera» dell'inefficienza, dell'impersonalità, del malaffare. Rideva della sua mitologia, scherzava sulle elezioni: «È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede, e guardo ancora la matita, così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia...». Allo Stato non credeva affatto, a differenza dei politici di sinistra che ogni tanto rispolverano il suo motivetto più famoso, «Libertà è partecipazione». Anni fa si rifiutò di cedere al PSI i diritti della canzone perché ne diventasse l'inno. Come avrebbe reagito di fronte a Santoro e Formigoni, che l'hanno gorgogliata ad Annozero? Forse, se fosse stato ancora in vita, si sarebbero risparmiati lo spettacolo.
Quando l'Unione Sovietica crollò, decretando la fine del socialismo e del sogno di tanti fortunati che non l'avevano mai toccato con mano, Gaber scrisse la celeberrima Qualcuno era comunista. Più che politico, disse lui poco dopo, era un monologo esistenziale: lui credeva in qualcosa che adesso non c'è più, e anche chi comunista non è mai stato può cogliere il senso di tale dolore. Un abbandono che ribadiva i versi tristi dell'inizio degli anni Ottanta: «Quella magnifica illusione non era mica un'idiozia. Ma tu che sei stato tradito nella tua aspirazione ora pensi che tutte le idee siano coglione. Razza già finita, senza neanche cominciare, razza disossata già in attesa di morire. No, non fa male credere. Fa molto male credere male». Si è spento dieci anni fa, il signor G. Non si è perso granché. Ora che il partito egemone a sinistra si chiama Partito Democratico, ne riderebbe. Democrazia? Cioè quella cosa per cui «tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io»? Stiamo freschi. Mi sono dilungato, la chiudo qui. Due parole ancora, sulla crisi e sul mondo politico italiano. Sono sue, e risalgono al 1978. Il sarcasmo è palpabile: «Bisogna far proposte in positivo, senza calcare la mano sulle possibili carenze: lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spappolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti!».
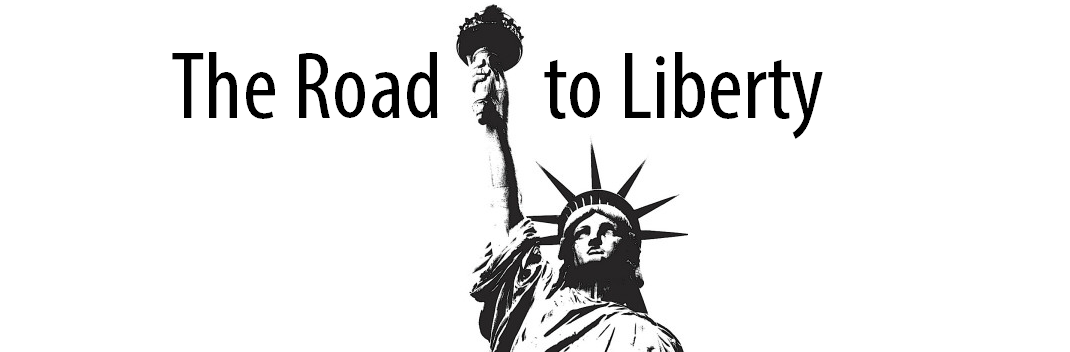
Nessun commento:
Posta un commento